

|
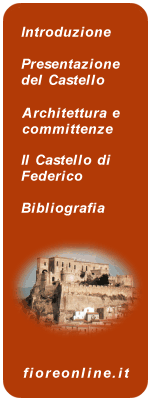
Pianta del Castello |
|
Descrizione ed analisi
Cominciamo dalla torre cilindrica (loggia tunn), attribuita a Federico, osservandola dall’esterno.
(
Le torri di N-O e di S-E hanno caratteristiche principali sostanzialmente
identiche; possiamo rivisitarle senza tener conto delle "differenze", che
abbiamo viste in occasione della prima visita. Notiamo
( Il livello del pavimento alla base delle torri, la posizione notevolmente bassa delle feritoie e di queste aperture (a livello o addirittura sotto il livello del fossato attuale), dicono chiaramente che, all’epoca della costruzione delle torri, il piano del fossato doveva essere molto più basso. Credo, insomma, che al tempo della costruzione delle torri un fossato non esistesse; il burrone che circonda il castello dal lato S-E doveva cingerlo anche su gran parte del lato Est; c’era un fossato naturale come quello che si vede in molti castelli dell’epoca (vedi: Lucera); i "fori" che attualmente sono a livello di fossato erano "strombature", cioè nicchie con feritoie e caditoie dalle quali i difensori, protetti, combattevano gli assalitori esterni (una strombatura nel muro esterno del fossato all’altezza del Murorotto è stata utilizzata come "porta" fino a qualche anno fa). Se il fossato attuale non esisteva, le torri di N-E e di S-E erano ancora più alte di adesso: la tipologia architettonica che ne risulta è inequivocabilmente angioina. Corona del Re. È un classico rivellino. Per collocarlo correttamente nell’analisi che stiamo facendo deve essere scorporato dal muro esterno del fossato, internamente, e dal muro del terrapieno che sovrasta il Murorotto, esternamente. La piccola torre che ne emerge ha base praticamente quadrata; i merli con le feritoie che si aprono ad Est sulla porta del Murorotto (accesso al castello ed al Paese), a Sud-Ovest sul terrapieno (che non c’era, all’origine); ha una scala che, inserita in un rettangolo di mura più basse delle cortine esterne, dopo pochi gradini "scompare". In realtà, un sotterraneo "sconosciuto" si trova nel fossato, tra la corona del Re e il muro interno del fossato ovest. Di questo sotterraneo nessuno conosceva l’esistenza: ne è venuta fuori la volta esterna a circa un metro di profondità, quando, per mettere a dimora alcune piantine di ulivi, mio nonno ha fatto scavare un solco longitudinale nel fossato, un po' a sinistra della strombatura-porta esterna del fossato (murata dopo la cessione del castello al Comune). A suo tempo ho cercato invano l’accesso dall’interno dei sotterranei. La volta del sotterraneo è poco inclinata verso l’esterno: pareva che andasse verso la corona del Re, a quella struttura rettangolare con gradini che ho ricordato poco fa. L’esistenza di questo sotterraneo (che con un semplice solco può essere ritrovato e studiato) è coerente con la funzione di "rivellino", attribuita alla corona del Re.
L’accesso dalla base della polveriera, o nelle immediate vicinanze, è sotto
il piano attuale di camminata (vi ricordo che il fossato attuale è più alto del
primitivo di 1-2 metri); non ricordo bene dove e come finisca la scala del
rivellino (mi riprometto di verificarlo presto). La posizione dei merli e delle
feritoie; la notevole altezza di tutte le pareti esterne, tranne quella
sull’attuale fossato; la presenza della "scala persa" e del sotterraneo (o
cunicolo coperto), che collega il castello con il rivellino, dimostrano che la
corona del Re è stata costruita a protezione dell’accesso al Castello ed
al Paese, nello stesso periodo in cui sono state costruite le torri di N-E e di
S-E. La corona del Re è angioina.
|
| Inizio Pagina |
|